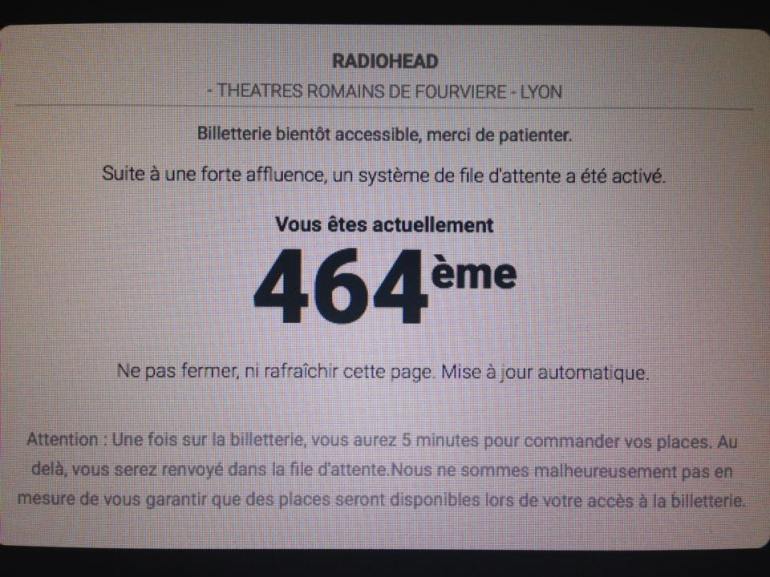“Gli Oasis?
Ma come, gli Oasis? “ gli dico con gli occhi fuori dalle orbite.
“Ma noi siamo dark, non possiamo andare ad un concerto Britpop. Non è concepibile”, sentenzio, dall’alto dei miei 19 anni, quando la coerenza a tutti i costi è un valore irrinunciabile.
Lui si piazza davanti allo specchio con gli occhiali scuri, il pizzetto appena tagliato, le gambe lunghe e magre inguainate in pantaloni neri di pelle, piegate in avanti, le braccia dietro la schiena e il mento proteso in avanti verso un microfono immaginario, ad imitare la tipica posa di Liam Gallagher mentre si sforza di diventare leggenda.
“Piccola”, mi fa, “questo disco è potente. E poi lui mi sta simpatico. Gli Oasis rimarranno nella storia, fidati.”
Io mi fido di lui, di questo ragazzo incredibile sempre vestito di nero come me, con 10 anni più di me, che mi ha aperto un mondo sconosciuto capace tradurre i miei moti interiori. Lui, scappato da una dittatura dall’atra parte del mondo, diviso a metà, mi ha fatto conoscere Dead Can Dance, Sisters of Mercy, Bauhaus, Einsturzende Neubauten, tatuati sul braccio. Mi fido di un musicista che fa risuonare le note del suo basso nello scenario piatto di una dormiente cittadina di provincia. Lo guardo e decido di assecondare questa sua follia del concerto; lui, un anarchico coraggioso, contro tutto e tutti, arrabbiato per un passato strappato e sostenitore dello spirito Punk del No Future.
Così partiamo in trasferta il 17 novembre del 1997, per assistere al tour Italiano dei fratelli Gallagher, armati di macchina fotografica Canon (lui) e zaino con contenuto rigorosamente monocromo (io). La sera del concerto, sugli spalti a Casalecchio di Reno, poco fuori Bologna, canto le hit della mia adolescenza trascorsa da poco (e non ancora finita) e mi sento stranamente a mio agio, in mezzo a tutti quei tagli di capelli Mod, polo blu e parka.
Passiamo la notte a parlare del concerto, delle canzoni, sognando una reunion dei Bauhaus e promettendoci di viaggiare seguendo i concerti dei gruppi che amiamo.
È già mattina e, occhiali scuri a coprire le poche ore di sonno, ci avviamo alla stazione di Bologna a prendere il treno. Alzo gli occhi a guardare l’orologio, fermo da 17 anni alle 10.25, e la mente inizia a viaggiare nei luoghi oscuri delle stragi italiane.
È lui a riscuotermi dal passato con tre sonori “Oh…Oh.. Oh!”. Non riesce a dire di più e allora seguo la traiettoria del suo sguardo: come in un sogno sfocato, sulla banchina del binario 1 vedo un tizio che cammina tale e quale a Liam Gallagher.
“È lui! Sono loro!” Esclama lui slanciandosi in avanti. “ Ma ti pare? Alla stazione! È un sosia” replico scettica, girandomi dall’altra parte. Ma lui è già partito: a grandi falcate si avvicina a quella che pensa essere la band di Manchester, e non mi resta che seguirlo. In effetti, a ben guardare, sono proprio loro, gli Oasis: incredibile ma vero, prenderanno il treno per la tappa successiva del tour: Milano.
Li marchiamo stretti, pedinandoli, e io sono presa dall’angoscia che Liam se ne accorga e che ci picchi selvaggiamente, come ha fatto poco tempo prima con un povero fan. Mentre penso questo, il cantante mancuniano si gira e ci guarda incuriosito, probabilmente domandandosi che ci fanno quei due neri figuri alle sue calcagna. Lui mi spinge e imbraccia la Canon, pronta a scattare. Io chiedo in uno stentatissimo inglese se possiamo farci una foto insieme e lui, inaspettatamente, annuisce entusiasta e mi fa cenno di andargli vicino.
Ci sono tutti gli Oasis, su quella banchina. Così si imprime su una pellicola analogica quella che ad oggi rimane una delle foto più belle a tema musicale, con una composizione perfetta, anche se ad essere in posa siamo solo io e Liam.
Lui, il fotografo musicista ribelle e visionario, si chiamava John Christian Vallejo.
Ovunque tu sia, Johnny, buon compleanno. E grazie, per tutto ❤️.