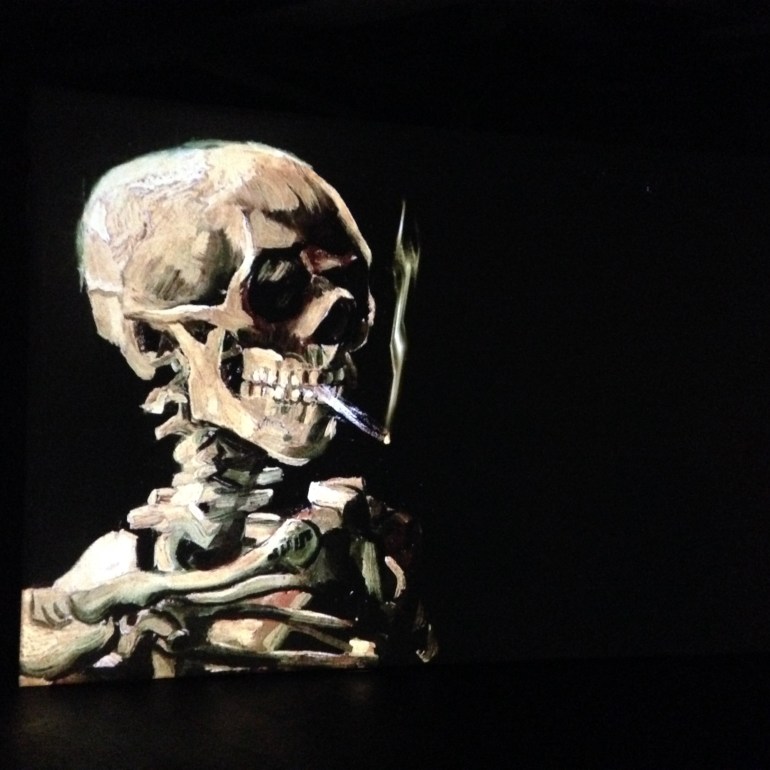Figura mitologica a metà fra una giornalista esperta di scoop e un necrologio vivente, dagli albori degli Anni Novanta ad oggi, mia madre si è volontariamente caricata della grave responsabilità di annunciarmi con spietata tempestività la scomparsa improvvisa e inaspettata di personaggi che hanno fatto la Storia dell’Arte, intesa nel suo senso più ampio, e la mia Storia.
La triste notizia veniva comunicata nell’ora a cavallo tra il sonno e la veglia, quando i sogni non mi avevano ancora abbandonato e la voce di mamma penetrava dallo spiraglio di luce della porta della mia stanza adolescente, nel sottofondo di Radio Rai, e da adulta, tramite un messaggio sullo schermo luminoso del telefono, che annunciava la voragine immensa lasciata dal personaggio in questione.
Ogni notizia funebre è per me legata indissolubilmente ad un elemento molto concreto.
1991: Who wants to live forever? Freddie Mercury se ne va con il profumo di caffè bruciato che sgomita in cucina; 1994: il bellissimo e dannato Kurt Cobain, profeta di una generazione, alle 7.00 di mattina viene proclamato morto dalla mia genitrice che aveva appena sfornato una torta al cioccolato e mi incitava impietosamente a suon di alzati che devi andare a scuola. It smells like a chocolate cake.
Il salto temporale che separa queste due terribili tragedie con quella successiva è enorme, enorme come il mio smisurato amore per l’artista in questione: gennaio 2016, mi sveglio nel freddo che la mia camera in mansarda mi regala alla sera e al mattino e vedo che mamma mi ha inviato un sms. Curioso, non me li manda quasi mai. Un lieve brivido che non mi spiego mi attraversa quando lo leggo. Crudo e impietoso, contiene solo 4 parole, tutte maiuscole: E’ MORTO DAVID BOWIE. Non ho smesso di piangere per almeno un mese ogni volta che ci pensavo. Facciamo un anno.
Tutto questo lunghissimo preambolo è per dire che, a 9 anni (numero altamente simbolico), dalla scomparsa di David, un’altra improvvisa, inaspettata e sconcertante perdita ha sconvolto la mia esistenza, e quella di tutto l’universo, oserei dire.
16 gennaio 2025: se ne va da questo mondo il genio DAVID LYNCH. E questa tragedia non mi è stata annunciata da mia madre, ma da un post inoltrato da un amico che non ha voluto aggiungere nessuna parola superflua a questo dolore, per paura o per pudore, chissà.
Ma perchè mia madre in quest’occasione è venuta meno al suo ruolo fondamentale? Me lo sto ancora chiedendo. Forse perché stavolta l’annuncio di questa scomparsa ha raggiunto l’etere di sera, quando mia madre è impegnata a cucinare, o a parlare al telefono con qualcuno, e non si cura più delle questioni del mondo, o forse perchè non ha capito quanto il regista statunitense abbia cambiato la mia vita e formato il mio immaginario, proprio negli anni in cui lei stessa mi annunciava le morti di Freddy e di Kurt, cercando di supervisionare i film che guardavo, i libri che leggevo, che fossero adatti alla mia età, per carità, che non mi scandalizzassero o sconvolgessero, che ero ancora una bambina.
In quegli anni lei aveva mosso una sanguinosa crociata per non farmi vedere il film Labyrinth, dove tutto è possibile, con il Duca Bianco nella parte del cattivo e affascinante Jareth, perchè lo riteneva un film horror. Erano passati mesi lunghissimi per convincerla che era soltanto un innocuo fantasy per bambini. Lei, che storcendo il naso alla fine aveva ceduto, non aveva fatto una piega quando Canale 5 aveva trasmesso la serie I segreti di Twin Peaks e mi aveva permesso di vederla senza nessun veto, senza nessuna incertezza o remora. Del resto, era pubblicizzato come una novità assoluta, un giallo, seppur con l’inquietante interrogativo “Chi ha ucciso Laura Palmer?”.
Dunque, alla tenera età di dodici anni, in seconda media, ogni mercoledì sera la mia mente incamerava con avidità quei personaggi allucinati, quelle storie sul precipizio tra due dimensioni, quelle inquadrature insolite e le musiche di Angelo Badalamenti, ipnotiche e misteriose. Ero completamente rapita da questa storia che sentivo essere totalmente diversa da tutto quello che avevo visto e conosciuto fino a quel momento. Non solo: avevo trascinato in questo mio entusiasmo anche molte delle mie compagne di classe, tanto da organizzare visioni collettive delle puntate clou della serie, spesso a casa di Claudia, che aveva una mansarda con la tv dove guardavamo il detective Dale Cooper parlare nel suo mini registratore, un oggetto di culto che ho chiesto come regalo della Cresima per incidere i miei pensieri e la mia voce. Con Stefania facevamo ipotesi su chi potesse aver ucciso Laura Palmer e Alessandra, per la sua festa di compleanno, aveva realizzato degli inviti personalizzati con le foto dei protagonisti della serie; a me era toccata, inutile dirlo, proprio lei, la grande protagonista incellofanata. Federica spacciava sottobanco Il diario di Laura Palmer che era uscito su Gente, romanzo pseudo-erotico scritto da Jennyfer Lynch, la figlia del maestro, che raccontava la vita della vittima prima del suo ritrovamento sulla spiaggia. Lo abbiamo letto tutte quante e poi è sparito nel nulla.
E così per due lunghe stagioni, fino ad arrivare all’ultima, sconvolgente e incomprensibile ultima puntata nella loggia nera, dove il nano ballava, Laura appariva e parlava al contrario, Cooper e Bob si confondevano. Nessun genitore, non solo mia madre, ha capito la potenza e la forza deflagrante di quella serie e di quel regista.
Di lì a pochi anni, ho visto tutti i suoi film, che avrei potuto riconoscere a occhi chiusi: Lynch era diventato una delle figure di riferimento della mia vita artistica.
Per questo ho pianto quando ho saputo che non apparteneva più a questa Terra. Ho pianto come si piange un Maestro, come si piange un amico.
Oggi, 20 gennaio, nel giorno della nascita del regista, ho aperto il mio diario segreto del 1992 e ho trovato, a caratteri cubitali, la citazione di Twin Peaks che mi aveva aperto un mondo:
Nell’oscurità di un futuro passato il mago desidera vedere. Un uomo canta una canzone tra questo mondo e l’altro: Fuoco cammina con me
Allora tutto mi è apparso chiaro, e ho pensato: grazie mamma, perché se tu ti fossi opposta a quella visione epifanica io forse non mi sarei innamorata del Cinema, non avrei iniziato a meditare, non avrei mai percorso strade perdute, non avrei mai ascoltato una musica suonata da un’orchestra immaginaria.
Il resto è Silencio.